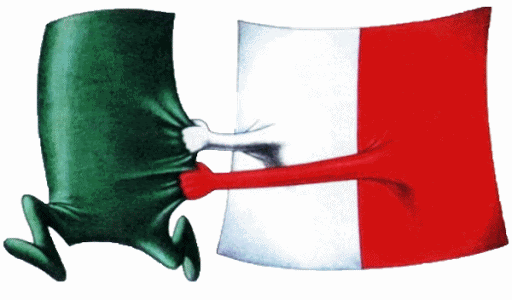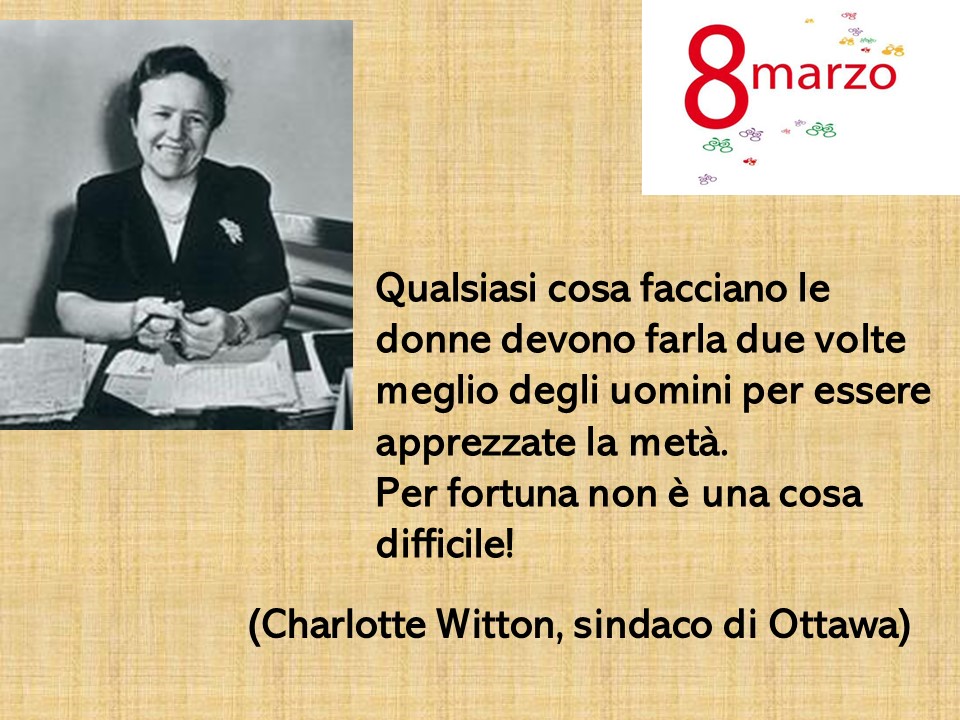26 aprile 1986. In Ucraina era la notte che precedeva un sabato qualunque. All’una e ventitré gli abitanti della città di Pripjat, dove sorgeva la struttura, videro un bagliore illuminare la notte. Era l’avaria alla centrale di Chernobyl, l’evento più disastroso della storia del nucleare civile. Quello che avrebbe cambiato per sempre la vita di milioni di persone, uccidendone un numero ancora imprecisato. Tutto nacque da un test di sicurezza: evidentemente non riuscito. Quando attorno all’una di notte furono disattivati i sistemi di emergenza per effettuare le prova, un’incredibile catena di errori, disattenzioni e inefficienze, unita alla tecnologia insicura del reattore di derivazione militare, portò al disastro.
A quanto pare il test doveva essere condotto di giorno, da personale appositamente preparato, ma poi, a causa di un parallelo calo nella rete che garantiva l’energia alla vicina Kiev, il via libera per ridurre la potenza del reattore di Chernobyl, senza rischiare deficit di fornitura, venne dato solo di notte, quando era in servizio personale all’oscuro delle procedure di emergenza.
Per una serie di manovre malaccorte la fissione diventò incontrollabile, il reattore raggiunse 120 volte la sua potenza massima ed esplose, scaraventando in aria una piastra da mille tonnellate e un’enorme quantità di materiale radioattivo: polveri, fumi, vapori carichi di radionuclidi. La nube radioattiva si spostò rapidamente da Chernobyl verso gran parte d’Europa. Secondo l’IAEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica) l’esplosione portò la contaminazione più elevata in un’area nel raggio di 100 km dalla centrale, con la concentrazione maggiore di isotopi di stronzio, cesio e plutonio. Per giorni l’allora Unione Sovietica tentò di nascondere l’accaduto. I primi dubbi in Europa sorsero il 28 aprile, quando in Svezia venne registrata una radioattività di gran lunga superiore alla norma. In Svezia non si erano però verificati incidenti nelle centrali nucleari, e neanche in Polonia, da dove i tecnici di Stoccolma pensavano che arrivasse l’allarme. Il 28 aprile un satellite americano mostrò le prime fotografie aeree dell’incendio al reattore di Chernobyl.
Nei primi dieci giorni successivi alla catastrofe si tentò con ogni mezzo di fermare la fuga radioattiva: elicotteri militari versarono oltre 1800 tonnellate di sabbia e 2400 di piombo sul reattore, ma solo il 6 maggio la situazione fu sotto controllo. Migliaia le persone che parteciparono alle operazioni, tra militari e civili. Si calcola che i “liquidatori”, operai, pompieri e soldati, reclutati e volontari, siano stati nei mesi seguenti circa 700 mila, provenienti non solo da Ucraina, ma anche da Russia e Bielorussia, repubbliche che all’epoca dell’incidente facevano parte appunto dell’Unione Sovietica. Da Mosca l’ammissione del disastro arrivò solo il 14 maggio da parte dell’allora premier sovietico Mikhail Gorbaciov. I “liquidatori”, ignari della reale portata del disastro, uscivano sul tetto del reattore armati di pale e badili per buttare in basso sabbia, boro, blocchi di grafite sopra il nucleo radioattivo. Ogni sortita durava al massimo 40 secondi e si andava avanti 24 ore su 24. Agli occhi di un pubblico preoccupato per le conseguenze della catastrofe, ma poco informato a riguardo, i liquidatori divennero gli eroi di questa tragedia.
Tornando a Chernobyl. Gli abitanti di Pripyat rimasero esposti alle radiazioni ignari dell’accaduto per 33 ore. Solo il 27 di aprile cinquantamila persone furono fatte salire a bordo di numerosi autobus mandati appositamente. Tutti si sono lasciati alle spalle la vita di tutti i giorni e sono partiti portando con sé solo i documenti e pochi oggetti necessari. L’annuncio del comune parlava di un’evacuazione temporanea ma si raccomandava con i cittadini di chiudere acqua, luce e gas. Quasi nessuno ha mai fatto ritorno nella cittadina. Secondo le stime, attualmente, nella cosiddetta “zona di alienazione” entro 30 km dal reattore vivono infatti circa 200 persone. Quasi tutti anziani, che scelsero di ritornare a casa dopo qualche mese, “per vedere quello stava succedendo” ed oggi vivono mangiando i prodotti che loro stessi coltivano nei terreni contaminati. Pripyat oggi è una città fantasma. Case, ospedali, scuole, strade: tutto è rimasto immobile da allora a raccontare quello che c’era e che non c’è più. Solo il degrado, la rovina e la vegetazione che ingoia tutto rivelano come in realtà siano passati 35 anni.
L’incidente di Chernobyl, sulla scala Ines di gravità degli incidenti atomici, è a livello 7, il massimo. Un disastro mai visto. Il più grave della storia, dieci volte più disastroso di quello avvenuto nella centrale giapponese di Fukushima nel 2011. Superiore decine di volte alle bombe sganciate durante la Seconda guerra mondiale su Hiroshima e Nagasaki.
Recenti dati solo di Russia, Bielorussia e Ucraina (le tre Nazioni più vicine al cuore del disastro) parlano di 200mila morti tra il 1990 e il 2004. Senza contare il totale dei malati di tumore. Solo in Bielorussia tra il ’90 e il 2000 l’incremento dei casi di cancro è stato del 40%, del 52% nella regione al confine con l’Ucraina.
Secondo il lavoro di due studiosi, Moeller e Mousseau (Università Curie di Parigi e University of Southern California), il numero di aborti spontanei è aumentato del 23% dopo l’indicente a Chernobyl, quello delle malformazioni congenite nei neonati dell’80%. Molto più drammatico è l’aumento del cancro alla tiroide.
L’incidenza è salita di otto volte in Ucraina. Mentre in Bielorussia si è arrivati fino a 26 volte di più.
Vi è tuttavia un altro aspetto: l’area intorno al reattore esploso in Ucraina è diventata la terza riserva più grande d’Europa di flora e fauna (lo stesso accade a Fukushima dopo 10 anni). Naturalmente i rischi non sono scomparsi. La resilienza della natura dimostra però che la presenza dell’uomo è più pericolosa di una esplosione nucleare
Dietro la scuola media sulla Sportivnaja, nel paesino fantasma di Pripyat, si vede ancora il pavimento di linoleum della palestra: le radici l’hanno spaccato e alle spalliere s’è avvinta l’edera. Le autorità ucraine previdero il deserto atomico per almeno 300 anni; Greenpeace per 20mila: “Invece quando la gente se n’è andata”, racconta un ingegnere della Chernobyl Exclusion Zone, un raggio di 30 km intorno alla centrale, “è tornata la natura. Le radiazioni sono ovunque, hanno effetti tremendi. Ma sono un fattore meno rilevante dell’assenza dell’uomo. Oggi questa è diventata la terza più grande riserva di piante e animali in Europa. E la rinascita ambientale è l’unica conseguenza positiva di quella catastrofe”.
Consentitemi una curiosità. In molti hanno ricordato, nel corso di questi trent’anni, che uno dei significati del nome Chernobyl, in ucraino, è “assenzio”. L’Apocalisse, al capitolo 8 versetti 10 e 11, recita: “Il terzo angelo suonò la tromba: cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si chiama Assenzio; un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono a causa di quelle acque, che erano divenute amare”.
Una coincidenza, certamente, ma resta il fatto che, quando si tratta del bene comune, gli uomini sanno superare le peggiori profezie.